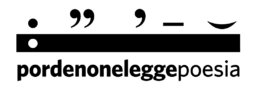La produzione poetica di Giovanni Turra, contenuta quasi per intero in Peepshow. Poesie 1996-2023, uscito a settembre ’24 per la collana Gialla Oro di Pordenonelegge, delinea un percorso di scrittura piuttosto eterogeneo, dominato dalla raccolta più nota, Con fatica dire fame, che comprende circa la metà dei testi raccolti e dispone di una costruzione complessiva più strutturata ed evidente rispetto ai libri o sillogi precedenti (Planimetrie, L’assedio e PEEPshow) e agli inediti de Il bosco degli spiriti.
E tuttavia se, archiviando questo dato, scorriamo i testi senza curarci della provenienza, possiamo accorgerci fin da subito della notevole tenuta formale di tutte le prove di Turra e, il che è forse più interessante, dell’agglutinarsi delle poesie intorno a certi nuclei tematici, come quello della torsione del corpo (già perfettamente tematizzata nel testo incipitale di Planimetrie) o della sua disarticolazione (ecco le poesie sulle mani, sui denti o sui piedi, notate a suo tempo da Franca Mancinelli1), dell’incomunicabilità (esemplificata nella vita di condominio) o del malessere che da psichico diventa fisico, e spesso descritto per analogia col mondo animale.
Sono proprio questi spunti, come piccole ossessioni, a costituire il collante più significativo del volume. Alcuni testi sembrano addirittura rispondersi a distanza di anni, come ad esempio Gli occhi avanti a sé (p. 117) e È di riposo lo stradino (p. 153), che ritraggono una medesima figura di fragile vecchietta, con quello che Cecchinel ha definito «un singolare miscuglio di solidarietà e cinismo»2, proprio dello «spirito nordestino»; o Superfici (p. 74), che fa il paio con Ci porremo di fronte (p. 152), dove l’autore sembra ripensare il posizionamento di due corpi che, dopo essersi dati a lungo le spalle possono «finalmente» guardarsi in faccia, conoscersi non da una superficiale «orografia» ma dai «lineamenti» sfocati («mobili e molli») che smettono di coincidere con i confini invalicabili di una gabbia.
Il progressivo sviluppo di questo materiale tematico, continuamente rimaneggiato, e i sottili mutamenti attraverso i quali è andato definendosi lo stile del poeta3, è quanto mi propongo di mettere in luce in merito a tre poesie, la cui lettura mi sembra possa costituire uno spunto per addentrarsi nel laboratorio di Giovanni Turra. La prima è da Planimetrie (1996-1997):
Dopo l’incidente sono in quattro
a metter mano dappertutto.
Un inventario di reliquie,
care cose pignorate:
la pignatta con le garze,
l’astuccio, le piante grasse.
In terra un carico di libri,
se tiene nei gangheri il battente
o viene via,
aperto sopra la finestra.
E uno sgabello scalciato in là,
con un nodo in cima.
Il componimento mette in scena una situazione che ricorda l’atmosfera di Il disperso di Cucchi ma soprattutto gli esordi di Fiori, per la precisione nella descrizione delle cose, degli oggetti ammucchiati rimasti come tracce o prove dell’incidente che si intravede solo filtrato dalla reticenza dell’autore – uno stile quasi elencatorio, da «inventario» appunto. L’analisi formale rivela poi un gusto per le allitterazioni (anche marcate, come «pignorate»-«pignatta») e il leggero ma continuo oscillare delle misure versali, che comunque non superano il decasillabo: versi adiacenti variano spesso per una sillaba, ma senza troppa regolarità, con un ritmo quasi claudicante (uno scazonte appena percettibile), che lascia il lettore seduto un po’ scomodo. Nella seconda strofa la costruzione va precisandosi, con due terzine ciascuna di due versi a tre ictus (novenario-decasillabo) e uno più breve, a due ictus. Nel finale assistiamo all’abbozzarsi del distico di endecasillabo e settenario, clausola di moltissime delle strofe più belle di Turra4; ben riconoscibile è anche la chiusa con la congiunzione «e», distribuita in questo caso su due versi, ma spesso in un solo verso-frase. La ragione del successo di questo stilema è forse da cercare nelle enumeratio – già osservate – e nella frequente coincidenza di verso e periodo. In un elenco di oggetti o situazioni nominate, la congiunzione viene pertanto a segnalare, anche da sola, che l’elemento che segue sarà l’ultimo della serie, generando nel lettore l’attesa della fine del testo.
Rivediamo questa chiusa nella seconda poesia (e nell’ultima che leggeremo), Toeletta #1, da Con fatica dire fame:
Lui pure nello specchio accanto a me:
mio padre, il mio
barbiere.
Ne spiccia un capillare,
e la coscienza s’apre.
Il rosso fanalino
del mio labbro sbucciato.
Io figgo gli occhi miei
negli occhi oscure fiaccole
di lui. Di faccia atterra
sopra la mia faccia,
incontrandomi al di là
del getto d’acqua. Mi sguarda.
E sana con un bacio la mia bocca.
Come nella poesia precedente, è qui ripercorso il topos dell’incidente e conseguente rimedio, ma con ben altre caratteristiche e connotati emotivi. I versi, più regolari rispetto al primo esempio, sono per la maggior parte settenari, sebbene il testo sia aperto e chiuso da due endecasillabi a maiore (i prediletti di Turra, in particolare quello con accenti in 2a e 6a sede, che occorre spessissimo). Nella prima terzina si ripresenta, distribuita però su tre versi, la già evidenziata configurazione ritmica di endecasillabo e settenario. Lo stile sintattico si definisce ulteriormente, le consuete frasi nominali si arricchiscono di attributi dal gusto quasi espressionista («rosso», «sbucciato», «oscure»), più facili da rinvenire che nelle raccolte precedenti.
Sia detto per inciso che queste frasi di lunghezza ridotta, marcate dalla punteggiatura, sono uno dei fondamenti su cui si reggono le sequenze di versi brevi e brevissimi5, abbastanza frequenti in Turra ma piuttosto inusuali nella poesia contemporanea.
Versi stabili e conchiusi, spesso sigillati dalla virgola o dal punto fermo6, un’accentazione molto fitta anche nei versi più brevi (questi settenari, ad esempio, sono quasi tutti a tre ictus), le inversioni nel periodo che impongono una lettura pausata e un lessico a volte ricercato, se non addirittura petroso, sono le altre condizioni che reggono questo verseggiare ripido ma saldo, che non si piega ad una rapida esecuzione. Ancora, il getto d’acqua del v. 13 è sì quello del rubinetto ma, insieme, come nell’immaginario medievale7, metafora della labilità delle cose, dello scorrere del tempo, oltre al quale è concesso al poeta di incontrare il padre.
Tale apertura a un orizzonte meno letterale e definito, confermata nell’ultima sezione di Con fatica dire fame, è forse il dato più vistoso degli inediti de Il bosco degli spiriti, che chiudono il volume: già il titolo, infatti, rimanda all’ambiguità di un luogo che è, in prima istanza, psichico. Siamo così al terzo testo, che segna l’explicit del libro:
Carnera Sgomberi
In strada, giù dal cordolo,
è la matta iridescenza della nafta,
screziato pappagallo che ridice
Carnera Sgomberi! Carnera Sgomberi!
Ma tu, mite Carnera degli sgomberi,
cosa mi porti in dono?
Un papavero di vetro sofiato,
dotore. E dove, dove?
Là su sul canterano del coredo,
dotore, con le foto.
Le foto, i volti. Nomi
e nomi che passai…
I lari tratti in salvo dai rovesci,
il fiore sonnolento che lì posa:
un guantone rugoso mi saluta
ed è la mano aperta di Carnera.
Ci accorgeremo a questo punto della presenza, sempre più rifinita, di molti dei tratti già osservati: i distici di endecasillabi e settenari8, le frasi nominali, che in questo caso evocano gli oggetti descritti con una dolcezza nuova, l’ultimo verso che si apre con la congiunzione (ma senza bisogno di interrompere il periodo con un segno di interpunzione, perché la quartina di endecasillabi è già lenta a sufficienza). Le ripetizioni, che già nel testo precedente giocavano un ruolo importante, si avvicinano fra di loro tanto da diventare il fatto stilistico più saliente del testo: pure a fronte di una scena dal significato evanescente (il «fiore sonnolento» dell’ultima quartina, che riformula il «papavero di vetro soffiato», è una ripresa dei «Lethaea papavera» dal Georgicon liber IV di Virgilio), esse sono garanti dell’emozione profonda che la poesia comunica. L’allitterazione mantiene comunque la sua importanza, come nella transizione «matta»-(«nafta»)-«ma tu»-«mite» (in assonanza con il «ridice» di due versi sopra). Gli endecasillabi sono costruiti con sapiente naturalezza e accolgono senza sussulti lunghi plurisillabi («pappagallo», «papavero», «canterano», «sonnolento»); collaborano nel costituire una propria armonia le effrazioni dei vv. 2 e 7, con gli accenti anomali in 3a e 7a sede. Il v. 4, dai due emistichi identici che, essendo sdruccioli, compongono un endecasillabo di 4a e 8a, è di una maestria davvero notevole in quanto del tutto inappariscente, e rivela al meglio la competenza formale dell’autore.
«Carnera», nome che difficilmente ci aspetteremmo in una lirica, è così ben trattato e preparato che, divenutoci familiare nel prosieguo del testo, ha l’incarico di chiudere i primi trent’anni di poesia di Turra. Nel congedo, la persistenza di quello che non va dimenticato («i lari tratti in salvo dai rovesci») e la dolcezza d’oblio del «fiore sonnolento», affidate al “gigante buono” Primo Carnera, si offrono al lettore subito prima di sparire.
Quanto rilevato sulla poesia di Turra è stato reso possibile per il tramite di una lingua sempre aderente alla realtà («millimetrica» l’ha definita Raimondi9), di un incessante e sfinente labor limae e di una disciplina del silenzio che sembra aver custodito pura l’ispirazione. Nel proliferare di libri di versi tante volte sbrigativi nella selezione del materiale o nella sua elaborazione (secondo le categorie del Contrasto pascoliano), per riconoscere il poeta non si può non fare affidamento sul binomio reticenza-pudore e sul senso ineludibile di una forte necessità.
1 F. Mancinelli, Giovanni Turra: Con fatica dire fame, in «Poetarum Silva», https://poetarumsilva.com/2015/05/14/giovanni-turra-con-fatica-dire-fame-recensione-di-franca-mancinelli/.
2 L. Cecchinel, Per Giovanni Turra, in «Quaderni veneti», 8, 143-146. Consiglio in particolar modo la lettura per uno sguardo più ampio alle tipologie tematiche dei testi di Con fatica dire fame.
3 Pur già dagli esordi originale e convincente, come rilevato da G. M. Villalta, che firma L’area delle parole abitate, postfazione a Giovanni Turra, Planimetrie, Castel Maggiore, Book 1998 .
4 Giusto qualche esempio: «A mezzo busto dentro una cornice,/in un giorno di sole.» (p. 69), «Ineccepibile controllo mimico./Geniale bricolage.» (p. 75), «intenti nello specchio a saccheggiare/ciascuno il corpo altrui.» (p. 79).
5 Un caso limite è rappresentato dall’ultima poesia di Con fatica dire fame, che attacca così: «Un è,/distinto dal mio/è, nel bosco,/in silenzio».
6 E difatti gli enjambements sono decisamente rari in questo volume, specie quelli, più forti, tra nome e attributo (che pure naturalmente si incontrano, anzi forse da questa parsimonia guadagnano in incisività, come al v. 2 del testo preso in considerazione).
7 Penso ad esempio al CXC del Rvf di Petrarca: «quand’io caddi nell’acqua, ed ella sparve».
8 Fra i quali il primo, «Ma tu, mite Carnera degli sgomberi,/cosa mi porti in dono?» è, a parer mio, il più bello dell’intero volume.
9 Stefano Raimondi, risvolto di copertina di Con fatica dire fame, Milano, La Vita Felice 2014.