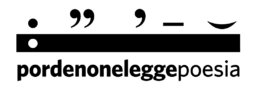Nota di lettura di Fabio Franzin a Gli anni degli altri di Marco Carretta, collana di poesia Nereidi, Vydia editore, prefazione di Francesco Targhetta
Come ha ben evidenziato Francesco Targhetta nella sua precisa e accurata prefazione a questa raccolta seconda di Marco Carretta (già espressa in versi brevi ma densi e acuminati, nella raccolta d’esordio: Per far vivere altro cadiamo, ma con isole di senso e tematica di una più immediata fruizione), la poesia dell’autore patavino “è sincopata ed ellittica, fatta di inceppamenti e reticenze, controcanti e correzioni”, così che il lettore, a una prima lettura, rimane stordito, fatica a dare, e darsi, a una logica, mettere ordine a un materiale lessicale che sfugge, ritorna, chiama altro “usavi male i verbi, li armavi”, in una sorta di pastiche linguistico apparentemente disordinato e fuorviante.
Eppure degli ordini, delle linee guida ci sono, nella scrittura di Carretta, ma vengono da lui volutamente mischiati proprio per provocare in noi tale sgomento e anche per rapportarsi a una realtà, così legata a un’informazione (Zanzotto docet: “ormai siamo disinformati di tutto in tempo reale”) che sviluppa solo lacerti di progetti e promesse, di cronache sempre più disumane e incomprensibili, intervallate da spot, frasi o immagini carnascialesche e volgari. Così, come se l’ordine si trasformasse in un ordigno che esplode e scompagina, e butta per aria consequenzialità, sintassi e persino la grammatica di ogni singola frase, che nel caso di un poeta diventa verso (che potremo anche definire come frase che si stacca dalla pagina per muoversi verso il lettore).
Allora evidenziamole queste linee guida (in un certo qual modo, sezioni), questi fili che, nella scrittura di Carretta, si attorcigliano, si strappano, vengono riannodati apparentemente a casaccio: i testi contrassegnati in numeri romani si riferiscono a una passeggiata dell’io poetante, qui espresso in terza persona, che si apre a dei ragionamenti sul passare del tempo; poi, i testi che portano un orario notturno in epigrafe, si riferiscono a un ammasso di pensieri ansiosi e intrusivi che si dipanano nelle ore cupe di un’insonnia e si svolgono dalle 3 di notte alle 5 di mattina (quando l’organismo umano è più indifeso, periodo in cui il moribondo spesso si abbandona alla morte); infine, quelli contrassegnati con data di anno solare, si rifanno a dei ricordi, così a definire un calendario memoriale.
Queste tre sezioni, o meglio, queste tre ipotesi di narrazione, l’autore le shakera, deliberatamente, come si diceva, in un disordine temporale e tematico così da disorientare chi legge e, allo stesso tempo, replicare i moduli frenetici e per “pillole” (qui dicasi pixel), che irrompono quotidianamente a scombussolare la comprensione di una realtà sempre più caotica e astrusa.
Io mi immagino Marco che, ideata e stampata per ordine cronologico e tematico la raccolta, abbia poi piegato e ripiegato ogni testo, inserito in un pallottoliere (tipo quello delle estrazioni del lotto), girato più volte e poi estratto a caso, bendato o meno: “toh, il primo testo è quello in numeri romani, il secondo quello con orario, e così via…”, così da assecondare e accordare la sua lingua ai rituali, e ai ritagli, dell’epoca in cui è scritta.
Queste le intenzioni dell’autore (al netto anche della suggestiva e irridente pratica immaginata appena sopra), in questo disordine programmato affiorano, a mio vedere, due evidenti enunciati che mettono in discussione (e che denunciano) le granitiche assertività su cui si è retta la società del nordest, di cui l’autore è figlio, dei suoi padri e dei suoi nonni, cioè di quella vocazione servile al lavoro (già tema centrale della prima raccolta di Carretta) e agli schèi cui tale territorio si è votato ciecamente dagli anni ‘70 del secolo scorso (sino a renderlo mito) fino al primo decennio di quello in corso, messo in crisi dalla crisi economica prima, se mi si permette questo facile gioco di parole, e quindi dalle generazioni cosiddette X, Y, Z, poco propense a vedere nel lavoro l’unica via percorribile per un appagamento personale.
A suffragare tale assunto, cito a caso dalla raccolta: “Il logorante lavoro di dover accadere”; “noi lavoravamo”; “appoggia il culo, lì resta”; “Di frequente fatica ad essere produttivo / di frequente né deciso né decisivo”; “La quantità, la validità”; “Ricchi di inerzia”; “presenza, mio caro, presenza” e, per chiudere con l’ossessivo adempimento a un codice di rettitudine all’orario di lavoro (o di suono della sirena): “un’ora prima piuttosto, mai cinque minuti dopo”. Poi, più lieve, ma non meno feroce, mi sembra di leggere la ricerca di un padre, che c’è, eppure assente, latitante, mancante: “suo padre su una poltrona ti tibie / assorto che chiama oltre”; “vede suo padre, / che è quello di un altro”.
Così, ecco che pur nel caos apparente di questa raccolta, certi versi si fanno aculei, spine che pungono e mettono in crisi chi scrive questa nota: anch’io sono padre di figli delle generazioni alfabetiche di cui sopra; anch’io posso affermare: “noi lavoravamo”; come posso dire, da brava formichina operosa del nordest, di aver sempre rispettato l’orario di lavoro: “Un’ora prima piuttosto, mai cinque minuti dopo”. Ma tale dedizione a un imperativo che era prassi comune, mi ha fatto essere al contempo anche un padre presente, affettivo, o solo un vecchio boomer rimbambito buono solo a far stolti confronti, come se esistesse solo un unico modulo o diktat a cui attenersi, con cui affrontare, o gioire, la nostra vita?
Ecco, quando il verso di un poeta mette in discussione le apparenti certezze di chi lo fruisce, quando un testo instilla un dubbio nel lettore e con la forza delle parole riesce a scavare dentro la noce indomita di chi siamo (o di chi crediamo di essere), siamo certi di trovarci di fronte a una voce che ci chiama. Importa poco se il nostro nome riecheggia in mezzo a un coro caotico. Lo udiamo, ci sentiamo afferrare. Questo basta.
Fabio Franzin