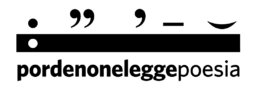Libro composito, imperniato su due sezioni (Sempreverde e Nel verde degli anni) rispettivamente suddivise in due e sei sequenze, L’età verde costituisce un tassello importante nella produzione poetica di Alessandra Corbetta, voce giovane e forte della poesia italiana. La natura del libro, al di là della complessa ma non casuale né azzardata strutturazione, indica piuttosto una strategia di allontanamento dalle istanze più immediatamente autobiografiche: nonostante gli spunti, i macrotemi e l’angolo di visualizzazione partano, come inevitabile, dal punto di vista della persona poetante, la cifra complessiva non è per nulla minimalista né diaristica, perché la strategia compositiva attinge – a partire dal titolo – da un ricco nucleo di archetipi, mitologemi e suggestioni fiabesche, di cui il colore verde è soltanto spia semantica.
Il colore verde, composto dal blu del cielo e dal giallo del sole, permea tutto il libro come perno del foregrounding, e ritorna nel titolo della raccolta, delle sezioni e delle sei sequenze della seconda (varie sfumature di verde associate ai protagonisti della galassia affettiva personale). Nell’iconografia letteraria il verde è associato alla gioventù (si pensi alla “forza che nel verde fuso” di Dylan Thomas, o persino ai “salad days” shakespeariani) e richiama immediatamente il bosco, sfondo di diverse poesie, e di qui un’ampia rete di significazioni, perché esso è il luogo dell’indifferenziato, del non (ancora) individuato, occasione di mistero e insidie; senza sentieri né riferimenti può essere rifugio (Robin Hood) ma anche causare smarrimento morale, incertezza sulla direzione da prendere.
Se “l’età verde” è diretto riferimento alla gioventù (tema della raccolta d’esordio di Corbetta, appunto intitolata Corpo della gioventù, puntoacapo 2019), va notato come per la poetessa la stagione centrale, quella della pienezza vagheggiata e a tratti già rimpianta sia l’estate (e L’estate corsara è il suo secondo libro, puntoacapo 2022): questa tensione addita dinamicamente il tema dell’uscita dall’eden della gioventù verso l’estate della vita, o diciamo l’uscita del bosco fatato verso l’aperto del mondo adulto e le sue problematiche concrete.
Da questo punto di vista, al registro fantastico e persino onirico della prima sezione succede quello più realistico della seconda, anche se, più che due distinte fasi, ovvero due stagioni cronologiche, è proficuo pensare le due sezioni come due diverse letture della vita, quella fantastica (imperniata sulla Bambina nel bosco) e quella realistica della Donna di fronte alla problematica apertura verso la vita. Anche la strategia affabulatoria è diversa: se nella prima fase domina l’impersonalità, lo sguardo dall’alto (persino oggettivo) sulle varie tappe che coinvolgono la Bambina, protagonista dei testi, nella seconda parte del libro (teste già il sottotitolo, Cronaca famigliare), pur non essendo attivata una modalità diaristica, è sempre presente un Tu a cui si indirizza il discorso, che rivela per contrasto l’Io poetante.
Le figure di questo vero e proprio processo di individuazione sono personaggi che nella prima sezione appaiono con la lettera maiuscola (il Padre, la Madre, il Maestro, l’Ombra, l’Amato), e che saranno appunto sviluppate in chiave realistica (mai esplicitamente denotativa) nelle varie sequenze della seconda parte, associate a specifiche tonalità di verde.
Le due poesie di apertura suggeriscono comunque uno scenario interpretativo universale: questi testi, un vero e proprio “prologo nel bosco”, inquadrano infatti la fabula come ricerca del sé femminile, tanto che la sottosezione seguente (La bambina C.) appare come un serie di exempla della lotta contro il mondo per affermare se stessa oltre i limiti del bosco. Sia nella prima che nella seconda parte abbondano poi le soglie da oltrepassare, le prove da superare, le verità del mondo di cui acquisire consapevolezza.
Se la galleria di figure esplicitamente “famigliari” è occasione di riflessioni sul loro ruolo all’interno del processo individuato (e, in certa misura, promosso) nel libro, sono due quelle che appaiono centrali: la stessa figura del maestro “intento a tracciare un sentiero” (p. 22) è una tappa primaria che conduce al seppellimento rituale, paradossalmente facilitato dal contrasto con l’Ombra, l’altro da sé che genera conoscenza: “mentre il Maestro traccia altri sentieri / lei lo colpisce e il cuore gli spacca / […] / poi corre in mezzo al bosco e danza tutta notte intorno al corpo del Maestro” (p. 31). Il riferimento preciso alla dimensione rituale dell’uccisione, con la danza iniziatica e orgiastica, autorizza appunto una interpretazione mitica.
L’altra figura di inevitabile centralità è l’Amato, l’Altro del tempo estivo, il “verde giungla” che rimanda a un potenziale negativo e angosciante: “il nostro problema non sono gli anni / piuttosto l’avere una stagione sola” (p. 86), e che rende evidente come l’estate sia destinata a passare, pur all’interno di una ciclicità “naturale”. Qui, lo scontro è modulato su variazioni dell’“Odi et amo” più o meno esplicitate, ma si gioca all’interno della tensione fra più tempi: quello ciclico della natura (l’estate, il verde della pienezza), quello della vita che avanza secondo il ciclo delle stagioni, e quello di una casualità (o necessità) insuperabile.