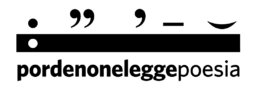Il valore di Giorgio Bassani poeta, se lo confrontiamo con l’autore del Romanzo di Ferrara a cui ha atteso per larga parte della sua esistenza, è ancora se non sottaciuto certamente non adeguatamente considerato nella sua interezza. Eppure alla poesia egli si è dato con pervicacia ed entusiasmo, segnatamente al principio e al termine della sua esperienza professionale e ce ne dà prova un nuovo, recente saggio dal titolo Giorgio Bassani. Pavana, licenziato da Officina Libraria per la curatela di Angela Siciliano, lettrice di lingua e cultura italiana all’Université Sorbonne Nouvelle – Paris III e da anni immersa con proficuità negli studi sull’autore ferrarese il cui catalogo ha accuratamente compulsato e curato.
La pubblicazione analizza e commenta criticamente “Pavana”, l’inedito dattiloscritto di versi, alcuni dei quali confluiti in Storie dei poveri amanti e altri versi (la raccolta apparsa nel 1945 e rieditata l’anno successivo con varianti), rinvenuti nel Fondo Arcangeli della Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna. Una “scoperta” certamente preziosa che fa luce sugli esordi giovanili del poeta nel periodo che va dal 1939 al 1942: invero è da sottolineare che il limitare di gioventù Bassani lo valicò con la prosa poiché già nel 1935 apparve un breve racconto sul “Corriere Padano” a cui seguirono svariati altri testi prima di farsi conoscere più concretamente nel 1940 con Una città di pianura nel quale, per evidenti ragioni di sicurezza, ricorse allo pseudonimo di Giacomo Marchi, il cognome della nonna di religione cattolica.
Si era nel fragore della recrudescenza del regime fascista, delle ignominiose leggi razziali, di una guerra a cui l’Italia non volle sottrarsi, nella messa a punto di quel gorgo concentrazionario che di lì a poco avrebbe condotto, come pecore al macello, milioni di ebrei, compresi nostri connazionali, alle camere a gas. È allora che Bassani, l’antifascista (e per questo condannato a due mesi e mezzo di prigione nelle carceri estensi di via Piangipane) e l’ebreo (ecco la doppia condanna, il doppio stigma sociale) si dedicò, di fronte a un “futuro incerto e oscuro”, a una furiosa attività poetica componendo “un centinaio” di liriche nell’arco di tre anni, alcune delle quali, 28 nella fattispecie, confluirono in Pavana, senza che però venissero mai date alle stampe forse per mancanza di un editore.
Letteratura e vita, in lui, sono strettamente legate, non agiscono in compartimenti stagni, e lo cogliamo anche dai testi contenuti nella seconda parte del volume in oggetto e anticipati da preziose note filologiche e dal relativo apparato critico in cui ritornano quei campi semantici, quei topos, quegli elementi fissi, in una frase quell’aria della canzone che rinverremo più avanti e nelle stesse poesie, si pensi a Epitaffio del 1974, e nelle prose. Ferrara è il mondo piccolo, il diuturno universo che abbraccia gran parte del lavoro poetico, ma ciò che più è interessante notare innanzitutto è una sorta di legame, di “dialogo” tra questa produzione e Una città di pianura: lo “stile dei miei racconti è insufficiente” scrive all’amico Francesco Arcangeli, al cui fratello maggiore Angelo (Nino), pianista e insegnante, Pavana è dedicata e che sarà “invitato” a difenderla dai letterati e a non dimenticarla. Ecco dunque che il verso interviene probabilmente anche a colmare una lacuna, a completare un’operazione sullo stile certo, ma più compiutamente sulla produzione stessa di un autore che si stava avviando verso una incipiente notorietà, prima che gli anni Cinquanta lo consacrassero definitivamente.
C’è in lui un’urgenza di scrittura, un grumo di espressività che dev’essere reso sulla carta: ad onta di uno dei periodi più tragici dell’umanità, e in ispecie per l’ebreo Bassani e per la sua famiglia costretti dal 1943 a spostarsi da Ferrara poiché divenuta città troppo pericolosa, il verseggiare acquisisce una valenza sua propria. Pavana contrassegna una cesura tra un’esperienza precedente di messa a punto di certi stilemi e il consolidamento del proprio percorso di scrittore e di uomo. Tra le suggestioni che immediatamente balzano all’attenzione vi è il titolo dato alla raccolta, quel “Pavana” appunto che nell’ambito musicale sta a indicare una danza rinascimentale, ma che a partire soprattutto dal Seicento passa dal suo significato legato alla coreutica per configurarsi come una composizione per pianoforte: è una scelta non casuale poiché lo stesso Bassani si dilettò con profitto nello studio di questo strumento frequentando privatamente un insegnante su invito materno. Per essere più precisi il richiamo dell’opera letteraria si ricollega alla “Pavane pour une infante defunte” composta da Ravel alla fine dell’Ottocento: e non è un caso se nella poesia eponima del volume ritroviamo i sigilli di un canto funebre (mesta pavana, crisantemi, lacrimava, la sera si spengeva), una “musica solitaria” nell’aria fredda di un novembre ch’è il mese dei morti, con il battito rado del metronomo a scandire il tempo dell’angoscia.
Siciliano, avvalendosi anche degli studi approfonditi in questo ambito compiuti da Enrico Scavo (suo compagno e musicologo al quale la pubblicazione è dedicata), ricostruisce l’ampio percorso dell’autore circa la genesi della poesia e l’elemento sinergico con le sette note. Uscendo dal ristretto cerchio di questa breve lirica, dove tra le curiosità annotiamo che Ferrara è citata per intero e non più con la sola iniziale a differenza che nelle opere in prosa fino alle “Cinque storie ferraresi”, ritroviamo più in generale il Bassani che percuote con il suo lucido realismo, non disgiunto da qualche debito “ermetico” come riferisce Montale e con termini mutuati dal quasi coetaneo Vittorio Sereni (pensiamo al verbo “incurvarsi” che troviamo nei Quaderni verdi bresciani o al vocabolo “sottopassaggi” presente in Frontiera del 1941), dentro la claustrofobica “chiusa città” estense che a partire dal 1943, con il trasferimento altrove, egli avrà modo di osservare alla distanza, macerando dunque ricordi e memoria per farne il centro di gravità di tutta la sua produzione.
Pavana in qualche misura “certifica” il tumulto, la tregenda destinati ad abbattersi sull’umanità nonché il lutto, l’esclusione, la morte, la marginalità come sostiene Anna Dolfi ripresa dalla stessa Siciliano nell’opera in oggetto: è un lavoro a suo modo completo e già maturo ed è altresì la visione di un domani privato, depotenziato della spontanea felicità dell’infanzia che “mai più ritornerà”. E quanto alla geografia reale e ideale dei luoghi se, come detto, Ferrara persiste quale elemento identitario e cornice insieme, nella raccolta assistiamo anche a una “fuga” temporale e spaziale, con lo sguardo al futuro, con le belle liriche su Monsélice e Voghera in cui nuovamente tornano elementi ricorrenti nella poetica bassaniana (i treni, le stagioni con la loro mutabilità, l’occaso, i vetri quale diaframma segnante l’opera omnia). L’ampio uso di figure retoriche e il ricorso reiterato alle ecfrasi (nella fattispecie legate all’ambito artistico) sono ulteriori caratteristiche precipue che già chiariscono il cammino dello scrittore lasciandoci quei segnali che ritroveremo a più riprese nella produzione successiva.
Lungo la riva del verso s’incuneano i sentimenti predominanti del turbamento e dell’angoscia, del disincanto e dello stupore che “attraversano” un tempo largo. “Sia suggellato qui quel poco che il cuore ha saputo ricordare” leggiamo nel Giardino dei Finzi-Contini: anche in Pavana è incistata l’interiorità di Bassani (nel periglioso guado di un’epoca) necessaria da conoscere per comprendere quel suo universo letterario e umano di “ferite indicibili”, per dirla con il Roberto Cotroneo del “Meridiano” a lui dedicato, sempre profondamente aperte.
Federico Migliorati
Al metronomo sordo d’una mesta pavana
sfiorivi: un crisantemo frangeva l’ombra smorta
della stanza. Smettevi di suonare: dalla persiana
lacrimava la polvere del giorno sul pianoforte.
Poi riprendeva la musica solitaria e insistente
quei pomeriggi tetri nel remoto novembre
della tua noia; la spera si spengeva: era sempre
di nuovo sera. T’alzavi, tornata indifferente.